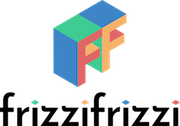Ci siamo. Domenica 27 maggio torna Cantine Aperte, manifestazione giunta ormai alla sua ventesima edizione e a cui aderiscono, quest’anno, circa mille aziende vinicole che apriranno le porte ai visitatori con degustazioni e incontri di vario tipo. Direi quindi di approfittarne per parlare un po’ di vigna e di cantina consigliandovi innanzitutto, se non siete mai stati né nell’una né nell’altra, di cogliere l’occasione al volo, perché niente dà l’idea di cosa significhi fare il vino quanto un contatto diretto con i produttori e con il loro territorio. Parlare con i vignaioli vi aprirà un mondo che limitandovi ad un approccio a distanza non potreste mai immaginare: incontrerete passione, ricordi, storie di sfide vinte e perse, di svolte e di ripensamenti, di fatica, di batoste e grandi soddisfazioni. Non sono mai storie banali quelle di chi dedica la propria vita al vino e sentirsele raccontare dai diretti interessati vi arricchirà.
Qui intanto possiamo cercare di immaginare come si presenta in questo momento dell’anno una vigna e che cosa succede in cantina con i primi caldi primaverili. Niente a che vedere con la goduria della visita in loco, ma spero serva da stimolo per passare dal virtuale al reale.
Incamminandoci tra i filari, ora come ora, resteremo forse un po’ delusi nel trovarci davanti un panorama che non aderisce all’immagine canonica del vigneto (quella rigogliosa con i grappoli in bella vista, per intenderci). La vite è in fase di accrescimento vegetativo in questo momento dell’anno e, per vedere le prime bacche, tocca aspettare metà giugno. La vitis vinifera ha infatti due cicli vitali, quello che va dalla sua nascita alla sua morte e quello annuale – a sua volta suddiviso in due sottocicli, vegetativo e riproduttivo. Insomma, rinasce ogni anno per tutti gli anni che dura un vigneto. Ma quanto dura un vigneto? Dipende. Mediamente, verso i 40 anni si può dire ormai vecchio (avendo dato il meglio di sé fra i 5 e i 25-30 anni) ma ci sono le debite eccezioni, soprattutto se parliamo di vitigni a piede franco. E qui tocca fare una piccola digressione per parlare di innesti, fillossera e, perché no, anche di Bacco. Anzi, partiamo proprio dal dio che regalò la vite agli uomini – e per questo sempre sia lodato!
 Molte sono le versioni del mito greco che riguarda Dioniso (il Bacco dei latini) ma, volendo fare una sintesi e senza andare troppo per il sottile, si può raccontarla come una delle tante scappatelle di Zeus. Pare che il buon padre degli dei si fosse incapricciato di una mortale, Semele, figlia di Cadmo re di Tebe – mortale sì, ma titolata. La fanciulla si concede a Zeus ma, in cambio, vuole che il dio le si mostri in tutto il suo splendore e, quando lui la accontenta, resta folgorata. Non in senso figurato: ci rimette proprio le reali penne. Zeus riesce a salvare il feto che Semele aveva in grembo e, cucendoselo in una gamba, porta a termine la gestazione. Di qui il nome di Dioniso, “dio nato due volte”. Per dovere di cronaca va detto che Era, moglie di Zeus, stufa marcia del cespo di corna che aveva in testa, perseguitò il frutto della colpa in eterno. Ma questa è un’altra storia…
Molte sono le versioni del mito greco che riguarda Dioniso (il Bacco dei latini) ma, volendo fare una sintesi e senza andare troppo per il sottile, si può raccontarla come una delle tante scappatelle di Zeus. Pare che il buon padre degli dei si fosse incapricciato di una mortale, Semele, figlia di Cadmo re di Tebe – mortale sì, ma titolata. La fanciulla si concede a Zeus ma, in cambio, vuole che il dio le si mostri in tutto il suo splendore e, quando lui la accontenta, resta folgorata. Non in senso figurato: ci rimette proprio le reali penne. Zeus riesce a salvare il feto che Semele aveva in grembo e, cucendoselo in una gamba, porta a termine la gestazione. Di qui il nome di Dioniso, “dio nato due volte”. Per dovere di cronaca va detto che Era, moglie di Zeus, stufa marcia del cespo di corna che aveva in testa, perseguitò il frutto della colpa in eterno. Ma questa è un’altra storia…
Quel che mi colpisce del mito di Dioniso è il modo in cui Zeus salva la vita a suo figlio, perché mi fa venire in mente com’è stata salvata la vitis vinifera qui da noi dopo l’attacco mortale della fillossera, due secoli fa. La fillossera è un afide che aggredisce direttamente le radici della vite e questo fa sì che la pianta muoia in brevissimo tempo, perché quando ci si accorge dell’attacco del parassita è già troppo tardi. Vi è mai capitato di vedere quelle rose solitarie in testa ai filari nei vigneti? Ora non se ne incontrano più tante, ma qualcuna la si vede ancora. Quelle rose stanno lì proprio per dare l’allarme. E anche per immolarsi, poverine, perché l’afide bastardo, quando arriva, si pappa innanzitutto la rosa che, morendo, avverte il vignaiolo del pericolo e gli dà tempo di intervenire per salvare le piante di vite prima che vengano attaccate a loro volta.
Non è con le rose, però, che sono stati salvati i nostri vigneti, bensì con gli innesti. La fillossera è infatti un gentile omaggio che ci ha fatto l’America e le piante di vite europea soccombono proprio perché non sono in grado di resistere a questo parassita estraneo. Non così le radici di vite americana, a cui la fillossera fa un baffo. La contromisura adottata fu dunque (e continua ad essere) quella di prendere i piedi di vite americana e innestarvi sopra la vite nostrana. Anche i nostri vigneti, insomma, sono nati due volte.
 Esistono tuttavia anche vigneti che sono ancora a piede franco (cioè non innestati) e sono quelli più longevi. La vite innestata parte con l’handicap e, sulla lunga distanza, non riesce a competere con chi corre sui piedi suoi. Per questo i vitigni a piede franco, che sono quasi sempre autoctoni, vivono di più e restano produttivi più a lungo (sempre se non s’imbattono nella fillossera). A volte si tratta di veri e propri esemplari in via di estinzione o creduti già estinti, salvati dall’abbandono e riportati in auge da vignaioli sapienti e con l’occhio lungo. Anche in questi casi, però, l’entusiasmo va concesso a chi merita davvero ed è consigliabile fare la tara a chi sbandiera ritrovamenti degni di un Indiana Jones dell’enologia: questi vitigni non sono la maggioranza, anzi, sono una elite. E se vi capita un enotecaro sussiegoso (almeno uno c’è e io l’ho incontrato) che giustifica i prezzi improbabili delle sue bottiglie raccontandovi che provengono da vigneti centenari, sfidatelo a dimostrare che si tratti di vitigni a piede franco, perché una vigna innestata a cent’anni non ci arriva nemmeno col rebirthing.
Esistono tuttavia anche vigneti che sono ancora a piede franco (cioè non innestati) e sono quelli più longevi. La vite innestata parte con l’handicap e, sulla lunga distanza, non riesce a competere con chi corre sui piedi suoi. Per questo i vitigni a piede franco, che sono quasi sempre autoctoni, vivono di più e restano produttivi più a lungo (sempre se non s’imbattono nella fillossera). A volte si tratta di veri e propri esemplari in via di estinzione o creduti già estinti, salvati dall’abbandono e riportati in auge da vignaioli sapienti e con l’occhio lungo. Anche in questi casi, però, l’entusiasmo va concesso a chi merita davvero ed è consigliabile fare la tara a chi sbandiera ritrovamenti degni di un Indiana Jones dell’enologia: questi vitigni non sono la maggioranza, anzi, sono una elite. E se vi capita un enotecaro sussiegoso (almeno uno c’è e io l’ho incontrato) che giustifica i prezzi improbabili delle sue bottiglie raccontandovi che provengono da vigneti centenari, sfidatelo a dimostrare che si tratti di vitigni a piede franco, perché una vigna innestata a cent’anni non ci arriva nemmeno col rebirthing.
Passeggiando per i vigneti, soffermiamoci a osservare in che modo viene allevata la vite e che densità di piantagione è stata adottata. Quest’ultimo aspetto è in diretta ralazione con la qualità, perché a parità di forme di allevamento, le densità più elevate danno migliore qualità globale, estratto e serbevolezza (ossia buona capacità di invecchiare) al vino che si produce. Più piante ci sono nel vigneto, meno grappoli graveranno su ogni singola pianta, favorendo così l’elevazione del rapporto buccia/polpa (ed è nella buccia che si trovano le sostanze più importanti per la qualità del vino). L’allevamento che permette ai germogli un portamento eretto o inclinato, poi, oltre a favorire la fotosintesi, migliora il rapporto tra superficie foliare e grappoli. In ogni caso, le forme di allevamento vigorose e con produzioni a ceppo elevate (cioè superiori a 5 kg d’uva per ceppo) non danno vini nobili né da invecchiamento, mentre avere pochi grappoli per pianta favorisce la qualità.
I tipi di allevamento – che dipendono dalle potature effettuate sulla pianta – sono molti e descriverli non è facile. Si va dall’alberello basso, alla greca, all’alberata di origine etrusca che manda la vite su per gli alberi fino ad altezze notevoli. Possono essere a sviluppo verticale (come l’alberello e il guyot) a sviluppo inclinato e orizzontale (come le pergole) o a ricadere. Ogni zona vitivinicola e ogni vitigno predilige una certa forma di allevamento, ma si può dire che in Italia le forme più diffuse siano l’alberello e la spalliera (guyot e simili) che insieme coprono circa l’80% del territorio vitato.
Lasciata la vigna, spostiamoci in cantina, dove in primavera si verifica un fenomeno che ha a che fare con la fede più ancora che con la chimica. O meglio, sulla carta appare come una banale reazione chimica, ma nella realtà si complica fino ad assumere i contorni di un mistero della fede. Sto parlando della fermentazione malolattica, fenomeno che riguarda i vini rossi in fase di fermentazione lenta e che verrebbe innescato (il condizionale è d’obbligo) dal rialzo termico primaverile. Questo tipo di fermentazione non avviene in modo prevedibile quanto quella alcolica, è più complicata e a volte rappresenta per i produttori una vera e propria incognita. Pare che avvenga in modo piuttosto lento già subito dopo la svinatura, ma assume notevole rilevanza in primavera. In realtà può avvenire in diversi tempi – comunque dopo la fermentazione alcolica – sia in modo spontaneo che indotto. Come reazione chimica consiste nella trasformazione, ad opera di batteri detti eterolattici, di una molecola di acido malico in una di acido lattico e una di anidride carbonica. In questo modo l’acidità del vino diminuisce, perché l’acido lattico è meno aspro e allappante di quello malico. E’ una fermentazione molto gradita nei vini rossi di buona acidità e grande equilibrio, a cui conferisce morbidezza e compiutezza.
 Detta così sembrerebbe semplice e, quando la si studia, anche inevitabile. Curiosando in cantina con un vignaiolo compiacente, si scopre invece che non è assolutamente detto che questa felice metamorfosi avvenga, tant’è che si può dare un aiutino a madre natura inoculando batteri lattici laddove il rialzo termico da solo non sia stato sufficiente a innescare la reazione – non vi azzardate a chiedere a un produttore di vini naturali se abbia fatto una cosa simile perché si offenderebbe a morte e potreste anche essere portati fuori dalla cantina per un orecchio.
Detta così sembrerebbe semplice e, quando la si studia, anche inevitabile. Curiosando in cantina con un vignaiolo compiacente, si scopre invece che non è assolutamente detto che questa felice metamorfosi avvenga, tant’è che si può dare un aiutino a madre natura inoculando batteri lattici laddove il rialzo termico da solo non sia stato sufficiente a innescare la reazione – non vi azzardate a chiedere a un produttore di vini naturali se abbia fatto una cosa simile perché si offenderebbe a morte e potreste anche essere portati fuori dalla cantina per un orecchio.
Per un rosso che deve durare un certo numero di anni, fare la malolattica non è un optional, è quasi un must. La differenza è riscontrabile al palato e, se la cantina che state visitando accoglie una botte di vino capriccioso che si rifiuta di ammorbidirsi coi primi tepori, chiedete al vostro ospite di farvelo assaggiare, magari subito dopo averne assaggiato uno che ha fatto il bravo: vi renderete conto immediatamente della differenza. Poi però non infierite sul povero vignaiolo, non diteglielo che fra i due non c’è paragone, o al limite ditevi certi che prima o poi anche il duro della situazione si ammorbidirà… per loro è un cruccio, ‘sta benedetta malolattica, siate comprensivi e rassicurateli.
E visto che vi trovate in cantina, approfittatene per dare un’occhiata alle botti, facendovi magari spiegare di che legno sono fatte, che età hanno, come mai si è scelto di tenere il vino lì e non altrove. Può essere l’occasione giusta per rendersi conto che non sempre il vino buono sta nella botte piccola, che la barrique è adatta a certi vini ma non ad altri e che lo scambio fra il legno e il vino che contiene è un’altra di quelle alchimie da gestire sapientemente, imparando dai propri errori e aggiustando il tiro anno dopo anno.
Ma questa è una storia di cui parleremo con più calma un’altra volta. Per ora buona scampagnata a chi scorazzerà per vigne e cantine, spero con un po’ di domande in più da fare ai titolari delle aziende.