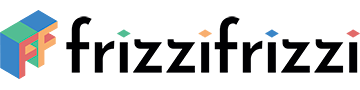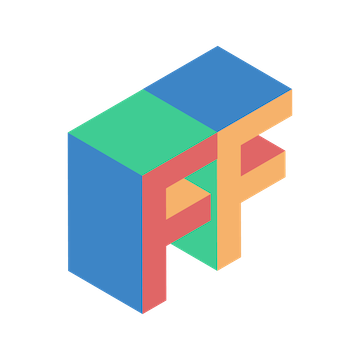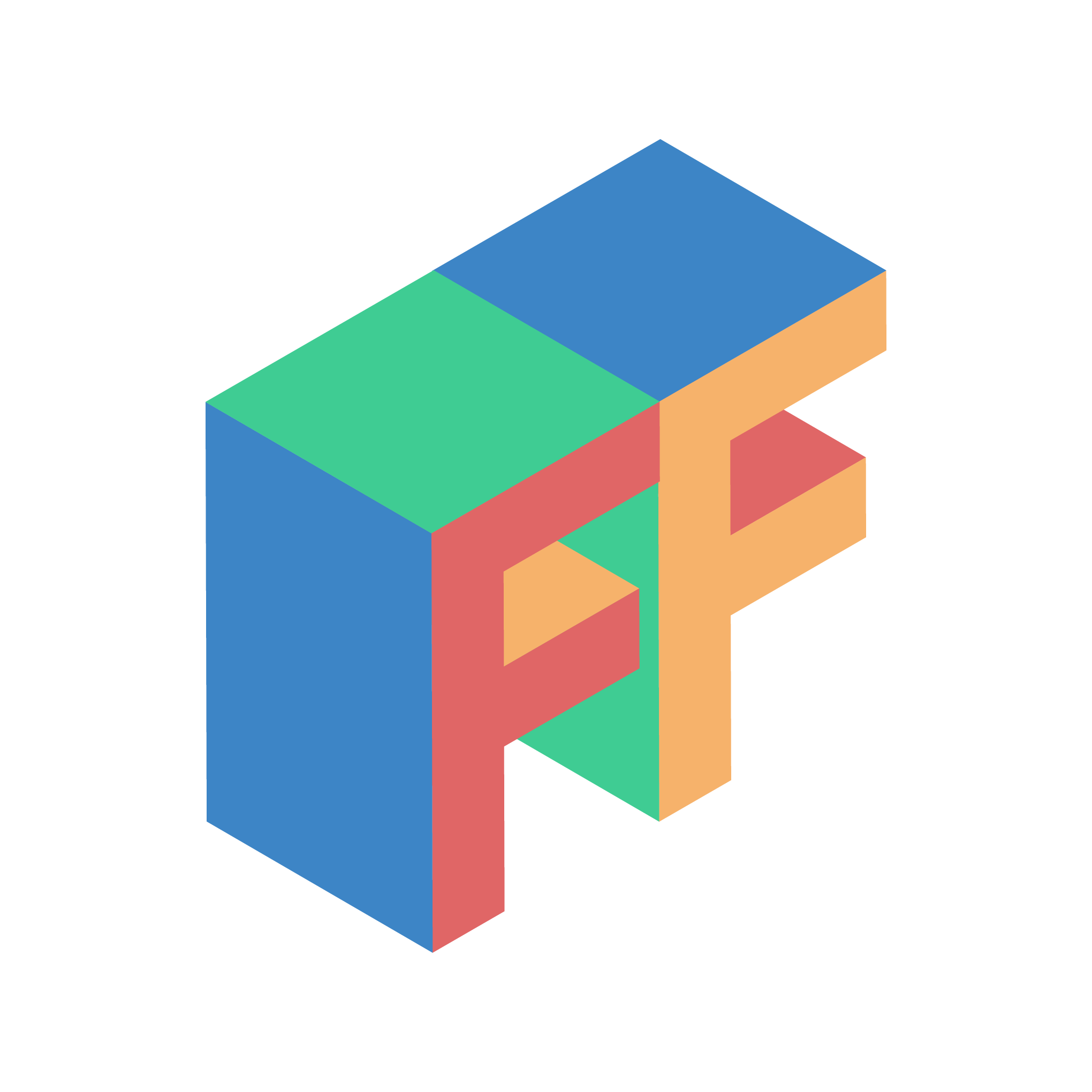Sono circa vent’anni che vivo a Bologna. Eppure, quasi ogni giorno, continuo a leggere giornali e notizie relative alla zona in cui sono nato e cresciuto. È un piccolo rito, piuttosto comune a tutti coloro che — per studio, per lavoro, per amore, per costruirsi una nuova vita o scappare da una che non si è mai sentita davvero la propria — si sono trasferiti più o meno lontano da quella che, in un posticino prezioso della mente, si considera ancora “casa”.
Non credo sia questione di nostalgia, o perlomeno non è soltanto quella. È più un tentativo di restare sintonizzati su un tempo “altro”, un tempo che ha un peso e un ritmo differenti da quelli in cui si è immersi quotidianamente.
Questo è tanto più evidente da un’app che ormai abbiamo tutti: quella del meteo. Difficilmente ci sarà un solo luogo, ed è altrettanto improbabile che la lista di paesi e città di cui si tengono sotto controllo temperature, venti e precipitazioni sia composta solo da posti rilevanti da un punto di vista pratico.
Sapere se in uno dei propri “luoghi del cuore” stia piovendo, se scende la neve o il cielo è tanto limpido da vedere anche le stelle piccine piccine, in qualche modo ci riporta lì, rievoca ricordi, ci astrae dal momento contingente per proiettarci una dimensione temporale più — come dire? — assoluta.
«Un cambio di paradigma», lo definisce Chiara Facchini, studentessa al terzo anno della Facoltà di Design e arti della Libera Università di Bolzano, che attorno a questa necessità di trascendere il tempo della produttività, il “tempo pratico”, ha costruito un progetto chiamato Timescape, che si sviluppa nell’ambito del design dell’interazione e della cosiddetta “user experience”.
Facchini ha 21 anni e viene da Moena, nella Val di Fassa — un “luogo del cuore”, che è stato importante ai fini dell’idea che c’è dietro a Timescape.
Come sono ormai solito fare con studentesse e studenti che ci inviano le loro tesi (anche se questa, tecnicamente, una tesi non lo è), le ho chiesto di raccontarmi il progetto.
In quest’ultimo periodo ho iniziato ad interessarmi sempre di più al design dell’interazione e della user experience. Così, quando ci vengono proposti progetti di ampio respiro cerco di inserire i device all’interno dei miei progetti, provando anche a stravolgerne un po’ le regole: la tecnologia mi incuriosisce tantissimo, ma al tempo stesso apprezzo la concretezza delle cose e sono consapevole dell’alienazione che può causare.
Timescape nasce all’interno di un corso di comunicazione visiva chiamato New Domestic Escape, proposto da Pietro Corraini assieme a Gianluca Seta e Valeria Burgio (per la parte teorica) e ispirato alla mostra del 1972 New Domestic Landscape.
L’obiettivo del progetto era quello di analizzare, in prima battuta, diversi aspetti della contemporaneità (con un focus sulle tematiche emerse durante il lockdown che ci ha costretti in casa), per poi, in un secondo momento, proporre delle soluzioni rivolte al futuro.
Durante il lockdown, personalmente, ho avuto diversi problemi con la gestione del tempo. Avendo molte cose da fare per l’università, era difficile capire quando fosse il momento di ritagliare del tempo per me stessa.
Questo tema sta diventando sempre più attuale, tant’è che recentemente ho letto che in UE si sta pensando di introdurre il diritto alla disconnessione.
Ho quindi deciso di lavorare sugli strumenti che ci consentono di tracciare lo scorrere del tempo.
L’idea era quella di far sì che quest’ultimi ci aiutassero a dilatare il tempo e a non sentirci sempre pressati dai minuti che passano.
Una lettura che sicuramente mi è stata d’ispirazione è stata Cronofagia di Davide Mazzocco.
La maggiore difficoltà che ho riscontrato durante lo sviluppo del progetto è stato il dover imporre a me stessa una sorta di cambio di paradigma.
Come la maggior parte di noi, infatti, la mia idea di tempo ricadeva continuamente nella produttività, nella ricerca di una funzionalità all’interno del mio progetto.
Ciò che invece, idealmente, stavo ricercando, era una dimensione bucolica, poetica del tempo: il richiamo alla natura è stato quindi spontaneo (soprattutto per me che vivo in mezzo alle montagne).
Dopo aver analizzato diversi strumenti del passato (che appunto sfruttavano i cambiamenti della natura e portavano sempre con sé un certo grado di approssimazione), ho quindi deciso di sfruttare la capacità dello smartwatch di ottenere dati in tempo reale su fenomeni naturali per realizzare i diversi quadranti.
Naturalmente, per far sì che l’orologio ottenga questo tipo di informazioni va specificato anche un luogo da cui prelevarle.
È in questo momento che ho pensato di dare la possibilità all’utente di scegliere il luogo che preferisce, che trasmettesse una certa tranquillità o che evocasse bei ricordi, introducendo una dimensione “nostalgica” all’interno del progetto.

(courtesy: Chiara Facchini)