Anni fa facevo un corso di fumetto a San Cesario sul Panaro in provincia di Modena. Per il corso passavo due giorni a San Cesario, ogni paio di settimane, per quattro lezioni in tutto.
L’unico hotel di San Cesario era carissimo così dormivo a Castelfranco.
Un giorno le bibliotecarie di Castelfranco mi chiesero se volevo fare qualcosa anche nel loro paese, oltre che dormire, così organizzammo un dopocena sul fumetto. Si trattava di una semplice chiacchierata sul fumetto ma quella sera vennero comunque una ventina di persone, un vero miracolo visto che nel teatro di fronte c’era Paolo Cevoli, un comico emiliano di Zelig molto popolare.
Nel pubblico c’erano diversi adulti appassionati di fumetti, alcuni genitori che accompagnavano i figli che avevo già visto a scuola. C’era un ragazzo di 14 anni che disegnava in modo fenomenale. I genitori ci tenevano a farmelo vedere. Era davvero bravo e aveva un umorismo suo, colto e particolare.
La serata passò piacevolmente, poi, al momento di andarmene, si avvicinò un tizio. Non capivo perché avesse l’accento romano e quel che mi disse dopo non lo spiegò. Comunque era un ragazzo della mia età, capelli lunghi lisci. Voleva farmi qualche domanda in privato. Mi accompagnò fino all’hotel parlandomi di un suo progetto che stranamente quelli di Tex gli avevano bocciato.
Si trattava di una storia sugli Shoshoni.

Gli Shoshoni (nome traslato da quello che gli avevano dato gli spagnoli, cioè sozzones) erano una tribù pellerossa e il nostro amico era un appassionato del West. Non so se vi è mai capitato di conoscerne di simili: era uno di quelli che conoscono alla perfezione i nomi delle tribù e il disegno delle divise dei Federati e che si lamentano quando in un fumetto economico come Tex il disegnatore fa un’uniforme in modo impreciso, ignorando una piccola variante introdotta in non so che anno.
La sua competenza in materia di pellerossa avrebbe dovuto aprirgli le porte dell’editoria e invece non accadde. Probabilmente si domandava anche il perché nessuna ragazza reggesse una conversazione con lui per più di venti secondi, eppure sapeva talmente tante cose sugli indiani!
Mi raccontò la storia grosso modo così: «Ce stanno questi caubbois che devono attraversà er deserto pé annà in un posto che stà proprio dall’altra parte der deserto. A un certo punto però nun possono passà e allora devono fare ’na deviazzione, sicché devono passà nel territorio degli Shoshoni».
A me sembrava un plot inutile, identico a un milione di noiosi episodi di Tex.
«In sostanza» dissi «ci sono dei tizi che devono andare da un punto A a un punto B. Non mi sembra un soggetto ricchissimo di aspettative».
«Eh, ma in mezzo ce stanno un sacco de cose» disse lui «Non sottovalutare gli Shoshoni».
«Forse allora di questa idea dovresti farne un soggetto scritto» provai a dire io.
«Ce l’ho!» fece lui, e con un gesto preparato lo estrasse dalla tasca e me lo porse.
Perché non sto mai zitto, pensai. Perché non provai a stordirlo subito con un’ombrellata e non scappai via?
Voleva che lo leggessi subito.
«Ma così? Per strada? Al buio?» provai a difendermi, ma l’amico degli Shoshoni era pieno di risorse.
«Là ce stà un lampione» e praticamente mi ci trascinò.

Mi ritrovo spesso nel cinema di Woody Allen e nei suoi personaggi. Per esempio in Boris di Whatever works (Basta che funzioni), nello scrittore di Manhattan o in quello di Deconstructing Harry (Harry a pezzi). Stardust memories è forse il film in cui complessivamente mi ritrovo di più.
Il regista comico che vuole fare film diversi, mentre tutti continuano a chiedergli film comici, sembro io con i miei libri: quando volevo fare libri divertenti nessuno li voleva. Ora che funzionano e vorrei fare dell’altro, tutti continuano a chiedermi quelli.
E poi gli incontri, le sedute di dediche, i fans che ti cercano, le foto in posa, ci sono molte similitudini tra il film e quello che mi capita, anche se, ben inteso, io non sono una star del cinema e il paragone tra il mio successo e quello di un regista come Allen non è nemmeno lontanamente praticabile.
Ciò nonostante ogni paio di settimane faccio un’intervista, quotidianamente qualcuno scrive da qualche parte del mondo per farmi i complimenti per un mio libro che ha letto o per propormi sue storie da disegnare, trascurando il fatto che non disegno libri da circa 10 anni, oppure si propone come illustratore per le mie storie.
I saloni mi prenotano ormai con un anno di anticipo. Ora devo già sapere con precisione cosa farò e dove sarò la prossima primavera, per definire gli spostamenti del tour.
Ai saloni e in visita nelle scuole rispondo a domande a raffica, poi, tra un incontro e l’altro mentre attraverso un corridoio per andare nella classe successiva, rispondo ad altre domande. Tutti vogliono un momento privato di confidenza con l’autore. Chi viene a prendermi in macchina di solito mi intervista per un’ora. Quando in classe risponderò alle medesime domande, rifatte dai bambini, si sentiranno orgogliosi di conoscere già la risposta.

Poi ci sono i regali: i disegni dei bambini, bottiglie di vino, libri. Non mi è ancora capitato di trovare una fan nel letto della stanza d’albergo vogliosa di fare sesso con me mentre il marito l’aspetta nel furgone parcheggiato fuori, come nel film, ma suppongo sia solo questione di tempo.
Per ora posso vantare una serie di stalker.
Di solito scrivono per avere una storia ma non ti mandano mai il book se glielo chiedi, perché sostengono di avere tutto sparpagliato. Se gli dai un appuntamento in Fiera per vedere il lavoro dal vero, lo fissano, poi disdicono con un sms cinque minuti prima di non farsi vedere.
Una, più insistente, mi tormentò per un anno spedendomi le sue cose, finché non la trovai effettivamente interessante e le scrissi una storia. Riuscimmo anche a venderla e a firmare il contratto. Dopodiché sparì nel nulla, senza ovviamente disegnare neanche una tavola. A distanza di tempo, aldilà della noia di dover ricollocare un libro già venduto, sono stato persino contento. Ho scoperto infatti che copiava in modo smaccato Camilla Engman, una pittrice svedese che non conoscevo e che successivamente ho incontrato per caso. In seguito ha cominciato a copiare Kitty Crowter. A quest’ora probabilmente starà tormentando qualcun altro per avere un’altra storia che non illustrerà mai.
Anni fa trovavo positiva la facilità con cui chiunque può trovare il tuo indirizzo e il tuo numero sul web, la cosa però ti espone anche come bersaglio di qualsiasi squilibrato abbia un’idea farneticante in testa e voglia condividerla con te.
Rimuovere l’indirizzo da qualsiasi sito pubblico e circondarsi di agenti ha risolto il problema. È vero ciò mi allontana un pochino dalle persone, ma è il prezzo da pagare quando tutti ti cercano.
Ogni tanto fantastico di raccontare i miei viaggi in un film.
La storia di un autore per bambini che fa strani incontri e che quando comincia ad avere successo si domanda il perché ha scelto di fare fumetti e libri, anziché suonare la chitarra in un gruppo rock.
L’autore potrebbe andare indietro a cercare tutti quelli con cui è stato ragazzo, i compagni di scuola, i vicini di casa, le ex, vagare in cerca del senso della vita fino a capire che ha avuto un gran fortuna che le cose gli siano andate così e gli funzionino bene, quindi deve continuare a scrivere: che faccia ridere o piangere non importa, basta che non rompa le palle con le sue lagne esistenziali.
Se facessi un film ci metterei senz’altro l’amico degli Shoshoni, ma ci sono diversi incontri divertenti che meriterebbero altrettanto di farne parte.
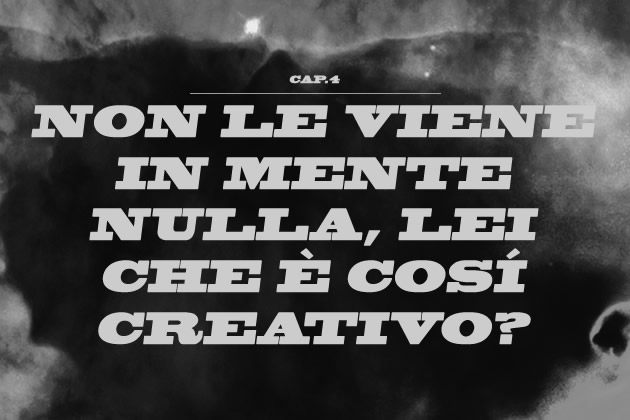
Anni fa mi chiamò un tale, dicendo di essere di un’associazione che raccoglieva fondi per i bambini affetti da non so più che malattia rara. Tutti gli anni facevano un concorso scolastico di disegno e il disegno più bello veniva usato per realizzare un piatto di ceramica, venduto per raccogliere fondi per l’associazione.
Mi chiese se io non potessi collaborare in qualche modo.
«Non saprei come» dico.
«Non le viene in mente nulla, lei che è così creativo?»
«A dire il vero, no. Voi a cosa avevate pensato? Forse vi occorre un giurato per il concorso?» azzardo io.
«No, pensavamo, visto che disegna così bene, se magari poteva farci qualche proposta».
Forse avevo capito. Erano stufi di fare piatti con disegni di bambini.
I disegni dei bambini del resto sono bellissimi quando li attacchi al frigo con un magnete e dopo qualche giorno li fai sparire. Ma farne piatti è una cosa diversa.
«Quindi volete un disegno? Ma cosa dovrei disegnare?»
«Non so, a lei che è così creativo magari sarà già venuto qualcosa in mente»
«A dire il vero no, stiamo parlando da soli cinque minuti. Al momento non ho nulla in mente»
Il tale sembrava deluso. Immaginai stesse pensando: che razza di creativo è?
Detesto quando faccio questo genere di incontri. Le persone pensano che un creativo debba creare fin dal mattino e che la creazione sia un gesto geniale ed evidente, come un fiore che sboccia, un fuoco d’artificio o un cane che fa la cacca. Restano delusi quando davanti ai loro occhi non crei nulla.
Comunque rimanemmo d’accordo che ci avrei pensato e che ci saremmo risentiti.
Prima o poi.

Un altro incontro fu quello con una scuola di fumetto. Non ricordo come ci capitai, comunque ci lavorai per circa un anno. La direttrice era estremamente cordiale e affettuosa, ma la sua espansività spesso faceva vibrare il mio “senso di ragno”.
Percepivo una specie di gelosia nei miei confronti. Non ho mai capito cosa fosse con precisione, ma deflagrò poco prima di Natale. Con una ragazza che insegnava lì, e che di sfuggita conoscevo già prima perché amica di un amico, realizzammo un librino con un mio racconto e le sue incisioni.
Questo oggetto innocente, tirato in pochissime copie solo per gli amici, scatenò la direttrice che accusò la mia amica di cercare di “portarmi via” dalla scuola, per realizzare un oscuro e non meglio precisato piano contro di lei.
Dopo di che cominciò a tormentarla finché non andò via. Io seppi la storia solo quando la mia amica decise di lasciare la scuola e subito dopo decisi di lasciare anch’io.
Ciò che ne seguì ha dell’incredibile. La direttrice mi fece una telefonata in lacrime, implorandomi di tornare, a qualsiasi condizione. Non appena mise giù il telefono chiamò il suo avvocato per farmi causa, perché avevo lasciato la scuola senza adeguato preavviso. Per qualche tempo mi sono aspettato di vedermela davanti al portone di casa con una motosega. Poi invece non è capitato niente.
E non ci fu mai nessuna causa, perché non avendo mai firmato nessun contratto, da collaboratore occasionale potevo andarmene quando volevo.
Ogni tanto mi chiedo dove sia finita e perché facesse finta che la ragazza che lavorava con lei fosse un’estranea, mentre tutti sapevano che era sua figlia.
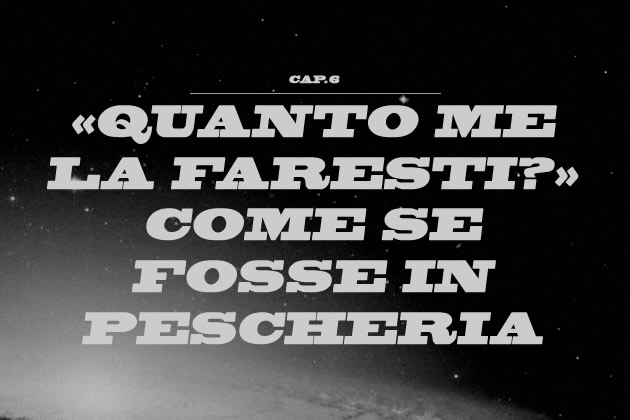
Poi ce ne sarebbero tanti da raccontare. Per esempio, l’illustratore che ti contatta per avere una storia, senza parole però, per avere più spazio per le illustrazioni. Oppure quello che ti contatta perché sei famoso e vorrebbe fare un progetto con te. Poi però gli viene il dubbio che la gente comprerebbe un eventuale progetto insieme solo per via del tuo nome in copertina e quindi ti chiede se non saresti disponibile a inserire eventualmente il tuo nome solo all’interno, in piccolo.
E poi c’è quello che invece vorrebbe una storia da illustrare, perché nessuno gliene scrive, e allora è disposto a comprartene una e chiede «Quanto me la faresti?» come se fosse in pescheria, in dubbio se comprare il tonno o il pesce spada.
È’ difficile capire quando stai diventando famoso. Forse quando gli altri cominciano a pensarti come a qualcuno che potrebbe farli sfondare?
Se è così, è cominciato parecchi anni fa.
Ero a Genova da Feltrinelli e incontrai un ragazzo che lavoravava negli uffici della Provincia dove avevo fatto servizio civile. Si sperticò subito in mille complimenti per tutto quello che facevo. Quando cominciano così, non resisto alla tentazione di stuzzicarli e farmi dire che cosa hanno visto di mio che li entusiasma tanto.
«Davvero ti piace tutto quello che faccio? Per esempio?»
«Beh, quello che fai su Linus, ho visto l’ultimo numero, bellissima la tua roba»
«Sull’ultimo numero non c’ero»
«Allora sarà stato quello prima.
«Ho saltato anche quello».
«Comunque era un numero con la copertina di Snoopy»
«È tre anni che non mettono Snoopy in copertina»
«Forse era un altro personaggio».
La conversazione si concluse come prevedevo: il tale scriveva racconti ma visto che come tali non riusciva a piazzarli nemmeno a sua madre, vedendomi gli balenò in mente un’idea: perché non farne dei fumetti?
Io avrei potuto disegnarli e lui scriverli.
Perché tutti quelli che scrivono racconti che nessuno pubblica a un certo punto hanno questa idea, che se li trasformeranno in fumetti diventeranno dei best seller?
Non lo so, ma è un’idea diffusa che hanno in tanti.
Oppure ce l’hanno in pochi e li ho incontrati tutti io.
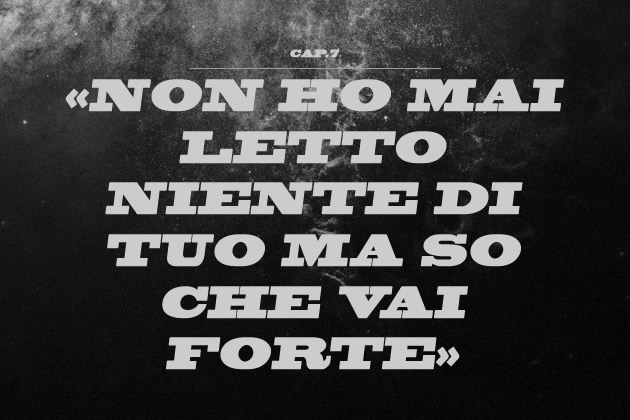
All’epoca mi sentii in imbarazzo per questo tale che fingeva di conoscere il mio lavoro solo per abbordarmi, ma poi ho capito che lo fanno tutti.
Ancora l’anno scorso mi contattò un illustratore che, ovviamente, voleva lavorare con me. Io guardai il suo sito, a tratti interessante, ma molto vario e disomogeneo, per cui gli chiesi, per capire, che cosa gli era piaciuto di mio, verso cosa si sentiva orientato. La sua risposta fu disarmante: «Non ho mai letto niente, ma so che in questo momento vai forte».
Alla fine ho smesso di rispondere anche a chi mi manda progetti, a meno che non siano ex-allievi o persone che ho conosciuto.
Chiunque infatti si sente autorizzato a spedirti della roba da guardare, si attende consigli. Io ho risposto spesso, deludendo le aspettative di successo immediato degli autori, ma indicando anche percorsi alternativi. Dopo rispondono sempre in pochi. Non capisco mai se è perché si sono offesi o perché reputano di non dover nemmeno ringraziare.
Naturalmente il successo non garantisce solo incontri spiacevoli. In generale però quello che accade è che ti allontana dalle persone. È difficile entrare realmente in confidenza con qualcuno, tutti ti cercano con uno scopo, cercano di prenderti qualcosa, come se fossi una specie di Gesù.
Quando non è così, resta il fatto che quando incontri tante persone non te ne ricordi nemmeno una. Qualche settimana fa un’amica mi disse: «Ma come fai a vedere centinaia di persone? Dopo ti ricordi che faccia hanno?».
Ovviamente no. Non mi ricordo nemmeno come si chiama quello che mi ha appena accompagnato all’aeroporto, ma non so cosa farci.
Fa parte della natura delle cose, penso.
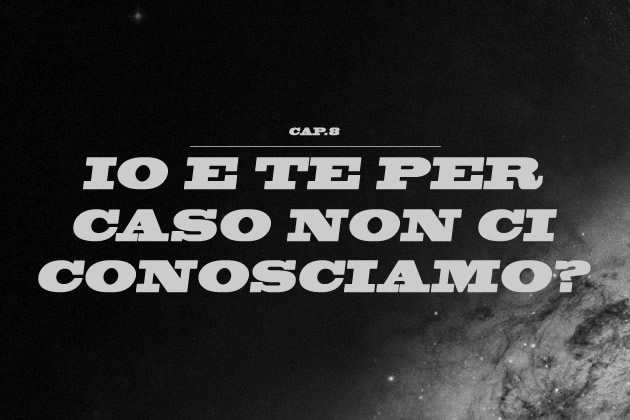
Tutti ti vogliono e ogni volta che mi muovo ci sono sempre più persone ad aspettarmi. Quando parli in un teatro vedi a stento la prima fila, il resto è buio. Quando incontri una classe vedi tutti, ma dopo che ne hai viste quattro in un giorno per due giorni di fila e tutti ti hanno fatto le stesse domande, non ti ricordi più della prima. E nemmeno dell’ultima.
Ai saloni quando vedo un bambino che si avvicina sorridendo e gli occhi che gli brillano capisco subito che è qualcuno che ho visto due giorni prima in classe.
Così dico, «Io e te per caso non ci conosciamo?».
E lui è contento.
Con gli adulti invece niente finzioni. Ammetto di non ricordarmi facce e nomi, ma devo dire che quando sei famoso gli altri diventano molto gentili e indulgenti, per cui nessuno si offende.
Non credo che sia brutto vivere così. Forse stabilisci rapporti superficiali con un milione di persone e nessuno veramente intimo, ma del resto credo sia un’illusione che abbiamo tutti, quella di conoscere i nostri amici e che i nostri amici ci conoscano.
Dopo i primi due anni di tour, ormai qualche anno fa, volevo smettere. Non mi divertivo più, avevo perso il piacere della novità e io mi annoio facilmente.
Inoltre essere sempre in un posto diverso è un po’ destabilizzante. Cambiare di continuo camere d’hotel, vedere i posti solo dal finestrino dell’auto, non ricordarsi nemmeno i paesi dove sei stato, non avere il tempo di visitare un museo.
Dopo ho capito che è peggio se sto fermo in un posto, e che quella del viaggio è una dimensione piacevole. Non essere in nessun posto mi rilassa, c’è qualcun altro che si occupa di portarmi a destra e a sinistra e io ho tempo per pensare.
Poi si tratta di salire sul palco e fare un po’ il tuo spettacolo, e di ripeterlo un paio di volte durante la giornata. Alla fine, anche guardando dal finestrino vedo più cose che se rimanessi sempre fisso in un posto, fosse pure il centro di Manhattan. E chiacchierando con le persone, anche in modo superficiale, scopri sempre qualcosa di interessante.
Quindi, dopo tutto, perché no?

L’amico degli Shoshoni mi portò sotto il lampione e solo alla luce mi resi conto che il soggetto era scritto a penna su un foglio a quadretti.
Gli promisi che l’avrei letto. Ma temevo che non sarebbe bastato. Mi vedevo già legato a un palo, circondato da Shoshoni ululanti.
Poi per fortuna mi squillò il cellulare.
Mentre parlavo al telefono salutai l’amico degli Shoshoni e attraversai la strada per rientrare in hotel sperando che non mi seguisse.
Prima di entrare mi girai.
Non mi aveva seguito.
Per un lungo istante mi aspettai di sentire il sibilo di una freccia shoshona e un bruciore tra le scapole.
Poi niente.
Ero salvo.



