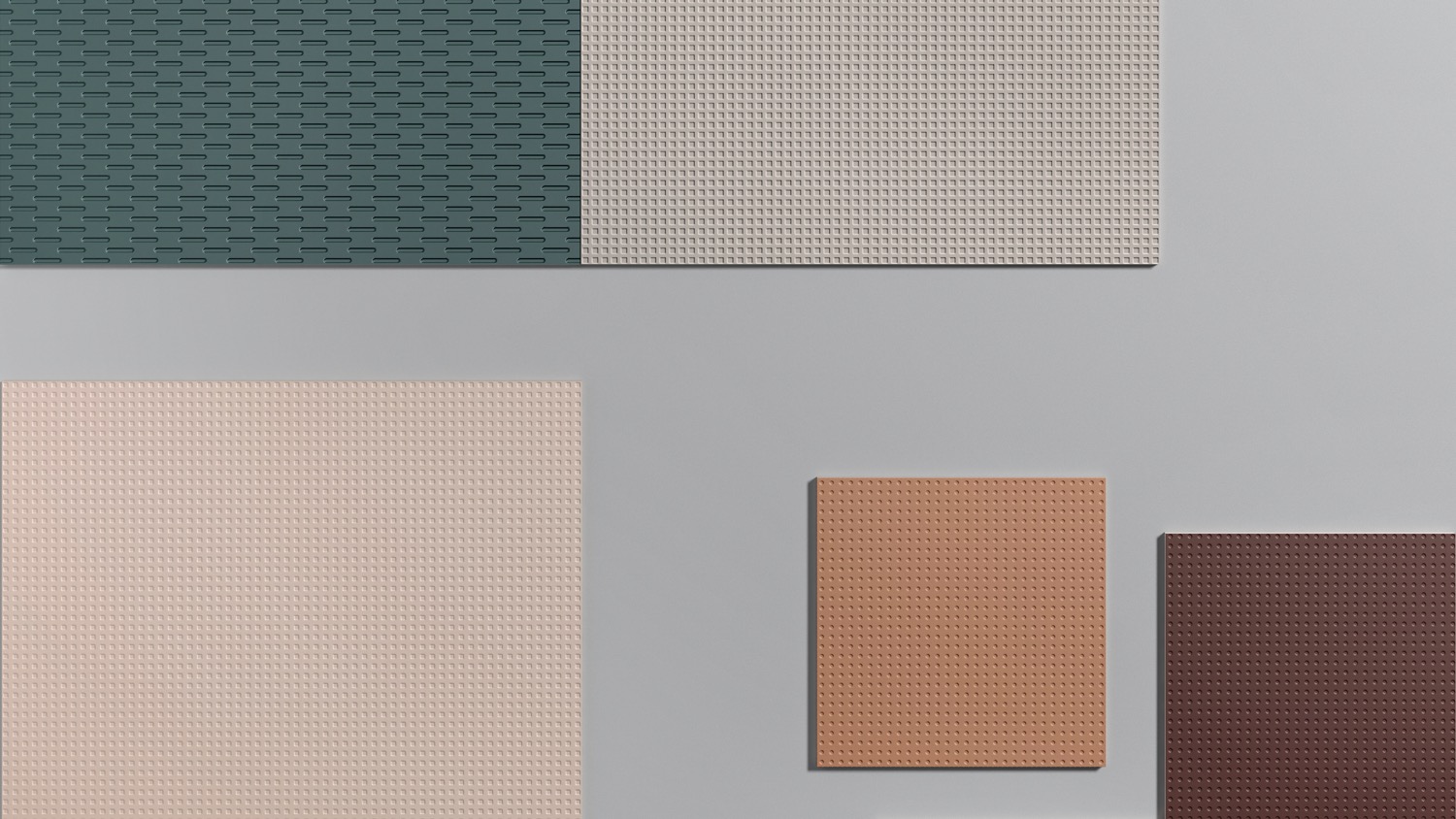Le idee progettuali dei maestri sono state fortemente rielaborate intorno agli anni Ottanta e Novanta da un gruppo di giovani designer chiamati “la generazione di mezzo”1. Si collocano a metà tra l’epoca dei Maestri e i nuovi linguaggi contemporanei. Alcuni, italiani, sono Antonio Cittterio, Alberto Meda, Stefano Giovannoni, oppure stranieri che lavorano con aziende italiane come Philippe Stark, Karim Rashid o Marcel Wanders. La loro è un’idea di progetto che si rifà alla lezione dei maestri ma con una impronta decisamente più commerciale. Il designer “di mezzo” non vive i frequenti dissidi dei Maestri con l’industria, anzi, si sente alleato con essa e sente propria l’esigenza primaria di puntare alla commercializzazione dei prodotti.
Luca Nichetto è un designer che ha acquisito molto della filosofia della “generazione di mezzo” adattandola però ai nuovi linguaggi e alle differenti dinamiche della società contemporanea. Può ad esempio progettare una sedia perfettamente funzionale e commerciabile che, a differenza dei suoi predecessori, ha come riferimento un video di Björk, oppure ideare un divano che riesce ad essere realizzato con un’unica cucitura. Il suo è uno dei più prolifici studi italiani: ad ogni Salone del Mobile presenta una quantità molto rilevante di progetti. Collabora con le più importanti aziende storiche del design come Cassina, Fontana Arte, Foscarini, Guzzini, Molteni, Venini, De Padova e altre. Ma ama anche lavorare con giovani imprese come MOOOI, Kristalia, Verreum.

Dal punto di vista formale, Nichetto, ha preso come riferimento il video “All is Full of Love” di Björk. Unire i temi del design classico, con nuovi linguaggi del contemporaneo, è processo tipico dei designer post-Maestri.
Ci incontriamo nell’Isola di Murano, in un ristorante poco lontano da casa sua. Lì conosce praticamente tutti: “Dario, so vegnùo da ti a fare na intervista”. “Ben, vedi de meter ‘na bòna parola”.
Essere nato a Murano ha i suoi vantaggi. Qui hai potuto conoscere la tecnica artigianale e soprattutto hai imparato come si dialoga con gli artigiani.
Sì, questa è sempre stata una grossa fortuna. L’architetto famoso parla con i maestri vetrai in un italiano difficile o in inglese. Il suo è un rapporto distaccato. Io con loro ho sempre potuto parlare in dialetto e questo è un enorme vantaggio.
E poi Murano è un posto incredibile.
Devo molto a quest’isola. Sono cresciuto in un luogo dove trasformare un disegno in un oggetto è facile come bere questo caffè. Ho iniziato a disegnare oggetti che non sapevo nemmeno esistesse un lavoro chiamato “designer”, lo sono diventato perché qui era naturale che lo diventassi.
Com’è iniziato?
Quando frequentavo l’Istituto d’Arte giravo per le fornaci di Murano a vendere i disegni che facevo. All’epoca non mi importava nulla di vedere realizzati i miei pezzi, mi interessava solo farci dei soldi per andare a divertirmi con gli amici durante l’estate.
Continuai a mantenere la tradizione di bussare alle porte anche durante il periodo universitario, e fu allora che incontrai Simon Moore [all’epoca art director della prestigiosa fornace Salviati, ndr]. L’ho capito molto più avanti, ma lui mi diede l’occasione che ha cambiato la mia vita: ricordo che mi disse, «compro tutti i tuoi disegni, ma non ne produrrò nemmeno uno. Vedo che hai del talento ma di aziende e di cosa si produce non ci capisci ancora nulla. Visto che sei di Murano, se vuoi, passa qui una volta alla settimana, così posso spiegarti e mostrarti un po’ di cose». Mi si aprì un mondo, ebbi modo di conoscere progettisti come Ross Lovegrove, Tom Dixon, Thomas Heatherwick, Anish Kapoor, Ingo Maurer e molti altri. Frequentai Salviati per sei mesi, quasi come se fossi un ragazzo di bottega. Quell’esperienza è stata per me come vent’anni di specialistica all’università, ho imparato più lì che in qualsiasi corso accademico.
E il tuo primo progetto in produzione è stato “Mille Bolle”, proprio per Salviati.
Sì, mi diedero un brief per disegnare un prodotto. La fortuna ha voluto che diventasse un bestseller dell’azienda. Avevo 23 anni, ancora non sapevo cosa fossero le royalties o una partita iva. Ma con quei soldi mi sono potuto permettere il mio primo computer. Così iniziai l’attività di designer, anche se non sapevo ancora bene cosa volesse dire veramente.

Oggi vivi tra l’Italia e la Svezia dove hai la tua famiglia e uno dei tuoi due studi. Puoi quindi osservare due realtà molto diverse: mi dici le principali differenze che trovi tra questi due paesi? Qual è il loro modo di intendere il progetto?
La Svezia non ha un’importante storia del design, gran parte dei designer scandinavi li troviamo in Danimarca o Finlandia. Oggi è famosa soprattutto per l’IKEA, quindi per il design mass market. La sua cultura progettuale si è formata soprattutto durante il Modernismo che, non a caso, solo in Svezia ha preso il nome di “Funzionalismo”. Sono progettualmente l’opposto di quello che siamo noi in Italia: la nostra è una cultura proveniente dal Rinascimento in cui la ricerca è quasi sempre basata sulla bellezza. In Svezia, invece, la funzione è praticamente un mantra. Mentre da noi ci si domanda prima di tutto se “è bello” e poi se “è comodo”, in Svezia è l’esatto contrario. Questo ha portato a due approcci molto diversi: quello italiano più orientato sulla qualità estetica e il dettaglio, e invece quello scandinavo basato sull’idea di forme senza tempo, e su dettagli che non devono definire troppo il prodotto.
L’Italia da questo punto di vista è diversa da tutti gli altri contesti.
Assolutamente. L’Italia è il Truman Show del design, è una bolla fantastica per tutti i designer del mondo, qui puoi veramente fare tutto con grande qualità, in un ambiente in cui l’impatto è importante: in altri paesi non è così.
Questo modo di progettare ha infatti influenzato oggi diverse realtà estere. Il modello italiano è stato esportato e copiato. Anche la sedia su cui siamo seduti ora [la Canal Chair, ndr] è stata progettata per Moooi, un’azienda creata da Marcel Wanders e costruita riprendendo chiaramente il modello aziendale italiano.

In Italia si sente ancora forte la presenza di figure mitiche, forse a volte mitologiche, come quelle dei Maestri. Che tipo di rapporto hai con loro?
Quando ho avuto la possibilità di lavorare con le aziende storiche del design ho scoperto per la prima volta che, accanto ai loro incontestabili capolavori, ci sono stati anche tanti progetti mediocri poi caduti nell’oblio della storia. Quelle figure leggendarie in fondo erano anche delle persone e come tutti facevano degli errori, ma molti dei loro progetti meno riusciti sono rimasti pressoché sconosciuti perché all’epoca non esisteva il web e non c’era l’amplificazione mediatica di oggi.
È stato per me importantissimo sapere che i Maestri erano come tutti noi, degli esseri umani.
Insomma finalmente potevi permetterti il lusso di sbagliare anche tu.
In Italia è ancora forte la presenza la figura dei Maestri, ti viene richiesto di essere riconoscibile, di “avere la tua voce”, di progettare oggetti icona. In Svezia non è così: ricordo la sorpresa di scoprire un altro modo di vivere il design, più tranquillo, più distaccato, mi sono anche chiesto «ma perché in Italia devo avere tutta questa pressione addosso?». Credo che molto dipenda ancora dalla figura dei Maestri.
Hanno avuto qualche colpa secondo te?
Accuso i maestri di non aver creato nessun tipo di scuola, perché per me un “maestro” è una persona che si preoccupa per il domani, è un mentore, e non mi pare che nessuno di loro abbia voluto esserlo.
È stato così per tutti?
L’unico ad essersi comportato da “maestro” è stato Sottsass, e i risultati si vedono nei suoi allievi. Sottsass aveva un forte carisma, una incredibile capacità ad aggregare le persone. Per lui creare dei collettivi era già di per sé un progetto. Aveva una cultura umanistica tale da riuscire a definire un linguaggio autonomo, diverso, proprio. Ma la cosa più importante è che lo ha saputo condividere.

La tua idea di design prevede che ci sia un rapporto con l’industria e la produzione in serie. Che cosa pensi del fenomeno dell’autoproduzione?
L’unico settore del design che non ha conosciuto crisi in questi anni è stato quello educativo, soprattutto universitario. Molte scuole d’arte hanno capito questo e lo hanno sfruttato anche in paesi dove l’industria è praticamente assente. Lidewij Edelkoort [ex direttrice della Design Academy di Eindhoven, ndr] ha scritto addirittura un famoso manifesto sulla morte del design in Italia e della fine della centralità di Milano: c’era l’esigenza di formare un movimento di autoproduttori, legittimando il design in un paese che fondamentalmente è senza aziende.
Io rimango dell’idea che l’autoproduttore sia fondamentalmente un artigiano, mestiere nobilissimo, ma fa altro. Io ho studiato e mi occupo di “disegno industriale”, il mio riferimento è la produzione in serie. Per me l’autoproduzione ha senso solo in quei rari casi in cui si ha bisogno di uscire dalle dinamiche dell’industria per sperimentare più liberamente, ma rimane comunque una ricerca che ha sempre l’obiettivo ultimo di essere portata poi nell’ambito della produzione seriale: altrimenti è fine a sé stessa, non ha senso.

L’industria è molto cambiata. Oggi, tutta una serie di professionalità che erano interne alle aziende — uffici tecnici, sviluppo prodotto, comunicazione — sono state inglobate negli studi di design.
Quasi tutte le professionalità che ho ora in studio, una volta erano dentro le aziende. I designer non si dovevano preoccupare di comunicare i propri progetti, oppure di andare negli stand di tutti i loro clienti a fare mille interviste, o prendere infiniti aerei in una settimana per meeting ed incontri. Era tutto delegato all’azienda.
E secondo te quando è iniziato tutto questo? Quando gli studi hanno cominciato a cambiare?
Il vero spartiacque ha un nome e cognome: Philippe Starck. Lui è stato il primo designer che si è posizionato come personaggio, facendo diventare l’autore molto più importante dell’azienda o dell’editore. Questo sdoganamento ha portato a tutta una serie di cambiamenti importanti nella professione. Oggi è normale che il designer si occupi dei testi da mandare ai giornalisti per raccontare i prodotti o che si preoccupi delle immagini del proprio lavoro che vengono divulgate. C’è un processo di personificazione del design, il designer non si occupa solo di progettare dei buoni prodotti, ma impersonifica e comunica i propri progetti.
Il tuo modo di utilizzare il web segue questa logica.
I social legati allo Studio Nichetto vengono curati da un’agenzia: assieme definiamo una strategia, con delle linee guida, ma poi loro seguono tutto. Per i social riguardante la mia persona non ho regole specifiche, inserisco immagini o testi random senza seguire una linea precisa. In quel caso racconto me stesso attraverso quello che faccio durante il giorno.

Ogni anno lo Studio Nichetto si presenta al Salone con una quantità importante di progetti. Hai molti collaboratori diversi tra loro, cosa richiedi a chi lavora con te?
In studio attualmente siamo otto persone, e produciamo una media di sessanta prodotti all’anno. Lavoriamo tanto e la mia fortuna è avere persone molto, molto brave a cui posso delegare senza problemi fasi importanti del lavoro. La cosa fondamentale è che i miei collaboratori abbiano ben presente che design non è arte, non facciamo forme. La forma deve sempre essere “giustificata da”: se mi fanno uno spigolo devono sapermi spiegare perché è stato fatto così. Su quello sono molto pignolo, a volte anche duro se le cose non funzionano.

Vivi gran parte della tua vita all’estero, hai quindi uno sguardo dell’Italia privilegiato. Oggi molti teorici si domandano se esista un design italiano, o meglio, se con i processi di globalizzazione abbia ancora senso parlare di stati nazionali.
Ti rispondo con una domanda, «esiste ancora la critica italiana?». Secondo me no, non c’è, e quella poca che c’è è così di corto raggio da essere ininfluente. Tornando alla questione che poni tu, se esiste o meno un design italiano, ti rispondo: «sì, esiste». Però va definito, e non c’è nessuno che attualmente se ne stia occupando. Perché se ci fermiamo ai parametri di cinquant’anni fa, allora posso tranquillamente dirti che quel design non esiste più.

E secondo te quale sarà la questione principale che dovrà affrontare il designer nel futuro?
Un tema del presente, ma anche del futuro è l’impatto ambientale. Spero non sia solo un trend, una moda, ma rimanga come questione da risolvere. La cosa va però affrontata con serietà, e non con le sciocchezze del tipo, “sedie fabbricate con i filtri del caffè riciclato”. Dobbiamo renderci conto che ogni nostra azione inquina e che lavorare con le aziende, creare prodotti, richiede una grande responsabilità. Dobbiamo inalzare il valore delle cose che facciamo, puntare sulla qualità, educare il consumatore ad acquisti più consapevoli e duraturi. Il futuro del design sarà produrre meno e meglio.
Grazie Luca.
Grazie a te Tommaso.