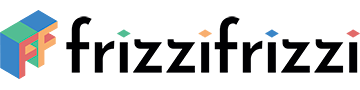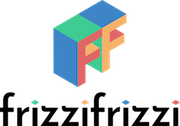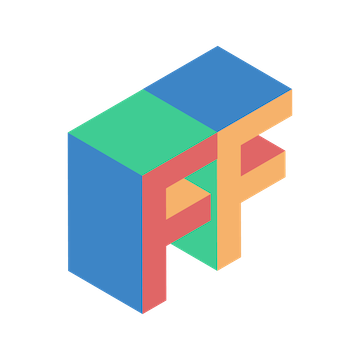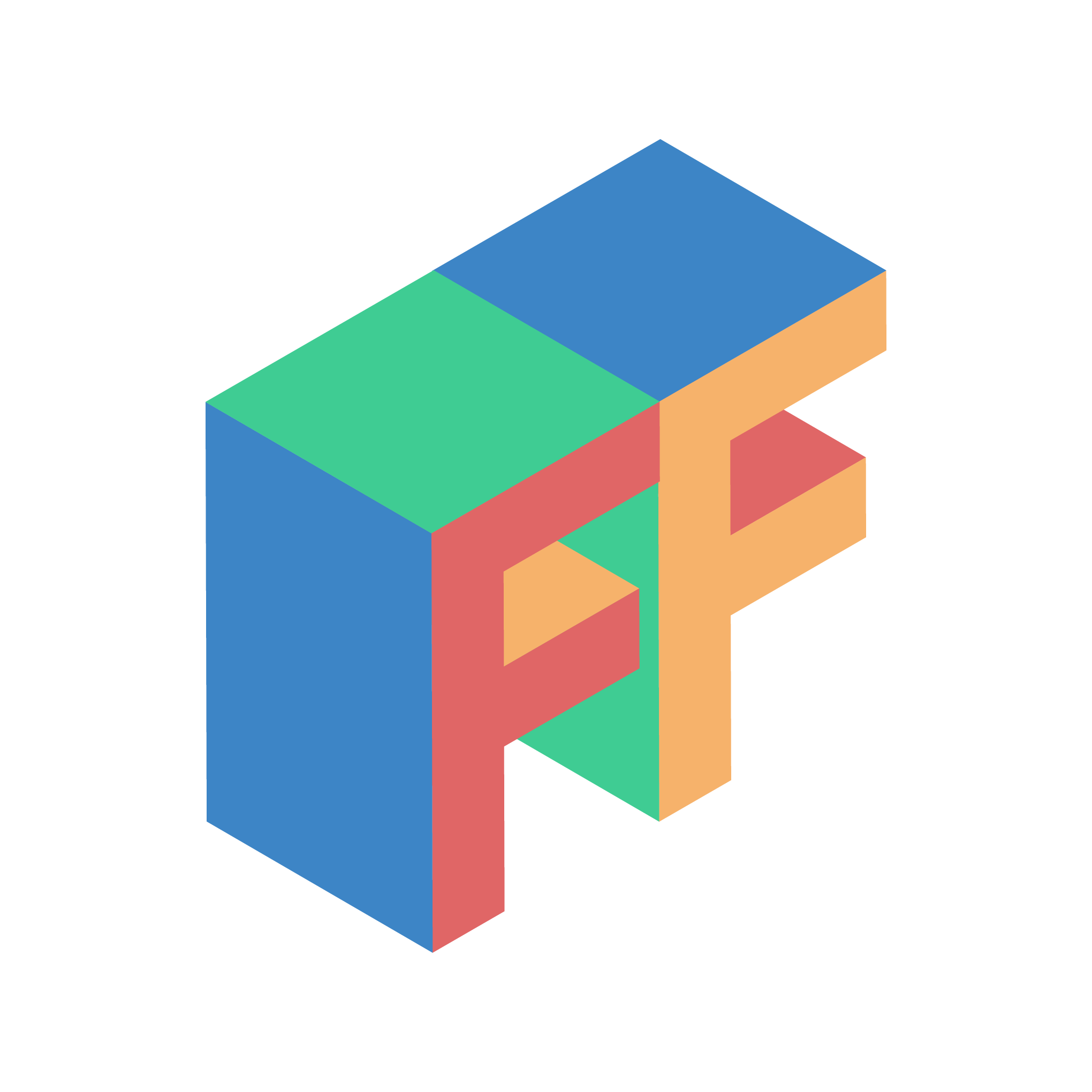L’autoproduzione non esiste. O meglio, è sempre esistita come arte nobilissima, ma si usava chiamarla con un altro nome: artigianato.
La mia non vorrebbe essere solo una critica terminologica, ma anche una piccola riflessione su quanto sta accadendo nel mondo del disegno industriale in questo momento.

Con il termine “autoproduzione” si intende grossomodo l’attività degli stessi designer di ideare e progettare manufatti, autorealizzarli ed arrivare a commercializzarli nei canali di vendita dedicati. Chi di voi ha avuto modo di vedere le varie design week tenute in nord Europa, i vari saloni satellite milanesi, o ha sfogliato le diverse pubblicazioni prodotte sull’argomento sa già quanto questo meccanismo produttivo sia ampiamente utilizzato, una realtà consolidata divenuta ormai al centro del dibattito collettivo.
La diffusione di questo modus operandi è figlia dei tempi, poiché i designers, soprattutto i giovani designers, hanno l’esigenza di vedere finalmente realizzati quei prodotti che sempre più spesso non vengono presi in considerazione dalle aziende, nell’intento di avere un primo confronto con il mercato e di poter incanalare la propria energia creativa su esperienze concrete.

Il design industriale è per sua natura intrinsecamente legato a temi quali la produzione in serie, la standardizzazione della forma, la razionalizzazione dei materiali, insomma tutte quelle dinamiche che prevedono un rapporto con una struttura aziendale. Chi autoproduce un oggetto si svincola da molti temi qui elencati ma si pone altre questioni quali il reperimento delle materie prime, l’acquisizione delle conoscenze tecnico-manuali o dei macchinari per la produzione, la progettazione e la realizzazione del packaging per il trasporto e la vendita del prodotto: il designer diventa insomma un “artigiano-imprenditore”, autore di tutti i passaggi che lo conducono dall’idea alla vendita di un prodotto.
Il design ha da sempre avuto forti rapporti con il mondo artigianale, si pensi a Gio Ponti o alla gran parte del lavoro di Ettore Sottsass, che ha sempre ammesso di avere fatto veramente design “solo con Adriano Olivetti e poco altro…”, ma che durante la sua carriera ebbe modo di realizzare pezzi magnifici con maestri artigiani.
Importante il tentativo di Enzo Mari negli anni ’70 di portare dentro l’azienda il valore del fatto a mano per “togliere l’operaio dall’alienazione della macchina”: in quest’ultimo caso i risultati furono commercialmente fallimentari e vennero abbandonati dalle industrie molto rapidamente.

La linea che separa designer da artigiano – pur essendo molto labile – passa per forza dal rapporto che si ha con l’industria.
Quello che noi oggi etichettiamo come “autoproduzione” non è la figlia povera del design industriale quanto piuttosto una naturale evoluzione della grandiosa arte artigianale.
Le tecniche, il sistema produttivo e le possibilità espressive sono tutti aspetti derivanti dall’artigianato. Riflettere sul termine “autoproduzione” non vuol dire relegarlo ad una questione meramente lessicale, quanto piuttosto aprire una riflessione su dove si sta indirizzando il futuro del design. Ritenere che l’autoproduzione abbia a che fare con il disegno industriale più che con l’artigianato non è solo una forma di snobismo, (un modo di vedere l’artigianato come una categoria inferiore rispetto al design), ma casomai un errore che limita le enormi possibilità tecnico-linguistiche di un linguaggio che sembra ancora legato a categorie filo-industriali.

Come sempre le crisi sono portatrici di cambiamenti: ci si riappropria di un sistema produttivo considerato “vecchio” reinterpretandolo con i nuovi mezzi a disposizione, come il taglio laser, le stampe 3D e i torni a controllo numerico.
Si sfruttano le potenzialità delle tecnologie digitali e si vanno ad intercettare nuove nicchie o nuove tribù di consumo sempre più consapevoli e sensibili ad una non omologazione del prodotto. Il linguaggio diventa “plurale” perché non più vincolato dalla produzione seriale o da logiche di mercato che tuttora ne segnano pesantemente i risultati, ma spesso si osserva uno scimmiottamento del prodotto industriale, poiché si continuano ad inseguire sistemi produttivi filo-industriali, arrivando ad ottenere prodotti che potrebbero essere facilmente realizzati in grande serie a costi inferiori.
Ma allora perchè non valorizzare la libertà che l’artigianato concede, approfittando del sapere che l’esperienza e la cultura del design industriale ci hanno permesso di conoscere ed approfondire? Autoproduttori, liberatevi della parola design, tornate a chiamarvi artigiani!