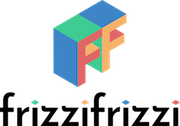Quando ero poco più di un bambino frequentavo spesso un manicomio. Non come ospite fisso se te lo stai chiedendo.
All’epoca, il comune della mia città aveva pensato bene di assegnare al nostro gruppo Scout, come sede in comodato gratuito, un’intera ala dell’ex manicomio cittadino.
La struttura chiusa da anni versava nel totale abbandono ma lo spazio all’interno dell’edificio e fuori, in giardino, erano abbondanti e funzionali per una masnada scalmanata di ragazzini di tutte le età.
Ricordo ancora bene la prima volta che i miei genitori mi accompagnarono in questo luogo così misterioso e dai tratti sinistri.
Finite le normali attività di gruppo, a volte io e qualche amico temerario ci spingevamo oltre i soliti confini che ci erano consentiti e raccomandati. La struttura che noi usavamo era composta da più piani, a noi ragazzi era riservato il piano terra con il giardino antistante ma, passata una serie di cancelli che in teoria avrebbero dovuti essere chiusi, si poteva salire tranquillamente ai piani superiori dell’edificio.

Nell’aria fredda e densa di muffa che avvolgeva la quasi totalità di tutti gli ambienti ci muovevamo con circospezione, pronti a balzare e scappare al primo segno di pericolo. Ogni finestra dell’edificio era chiusa da grate fitte e assicurate con grossi ganci ai muri scrostati e malridotti da anni di infiltrazioni, le porte delle varie stanze che si aprivano lateralmente al corridoio centrale erano per la quasi totalità sfasciate da calci di misteriosi visitatori.
L’interno delle stanze era quasi sempre un disastro ed era stranamente emozionante e anche un po’ spaventoso raccogliere da terra i resti di coloro che in quelle strane stanze avevano dimorato e sofferto. Ci stupivamo sempre di trovare molti giocattoli, sopratutto bambole dai capelli tagliati e sciupati ma anche vestiti, montagne di indumenti sporchi e umidi che in mucchietti disordinati facevano da tana ai piccoli topi che ogni tanto scappavano rasente i muri.
Come nei film che avrei visto molti anni più tardi a volte inframezzata tra una camera e un’altra comparivano le stanze imbottite. La trapuntatura sfilacciata del tessuto pendeva irregolarmente a brandelli da quelli che sembravano essere stati pannelli disposti con ordine maniacale, schizzi di non so quale materia umana coloravano l’ormai grigio ordito della stoffa a formare macchie di Rorschach dal significato oscuro.
Spesso la paura era molta e spaventati da rumori inesistenti fuggivamo rapidi per le scale verso il giardino per poi aspettare con ansia la settimana successiva, quando avremmo potuto iniziare di nuovo la nostra esplorazione segreta.

Una volta mentre ci addentravamo al terzo piano scoprimmo la zona dei bagni e rimanemmo tutti sconvolti da quell’inferno che doveva essere la vita dei reclusi. Le docce non esistevano ma in compenso c’erano delle grosse vasche da bagno di cemento armato, fredde, immense e con le rubinetterie nascoste lontano, c’erano ancora le cinghie e i fermi per le caviglie e i polsi fissati a questi grandi specchi di costrizione.
Le vasche leggermente sagomate all’interno dovevano accogliere forse più di una persona e non oso immaginare l’angoscia di essere legati mentre l’acqua ti sale lentamente addosso per lavare peccati di cui neanche sei consapevole, per mondare dalla tua persona angosce e incubi che non hai mai richiesto.
Le condizioni generali di tutta questa parte dell’edificio erano francamente da voltastomaco, i bagni che i “matti” avevano continuato ad usare ancora per molto dopo la chiusura dell’istituto erano pieni di merda secca e rappresa, schizzi di materia fecale adornavano pavimenti e muri, carta igienica marmorizzata giaceva pietrificata a tappare i buchi delle turche aspettando un addetto fantasma che non avrebbe mai più scaricato lo sciacquone.

Al tempo girare per l’istituto era un gioco e una pazzia. Anni dopo, parlando con chi era con me e avendoci riflettuto, anche io mi sono accorto dell’incredibile abominio che quel luogo aveva rappresentato per i suoi ospiti. Quando nelle nostre esplorazioni incontravamo qualcuno dei vecchi ospiti ci stupivamo sempre, erano perlopiù persone di una certa età che avevano continuato a vivere in quegli edifici nascondendosi dal mondo che molto tempo prima li aveva rifiutati. Non avendo probabilmente altro posto dove andare alcuni di loro avevano scelto di rimanere in quella che era la loro casa, la loro normalità.
Ci siamo messi a parlare molte volte con i matti quando frequentavamo l’ex manicomio ed alcuni di loro li porto ancora nel cuore perché con quelle facce buffe, distrutte da farmaci e angherie era facile volare con la fantasia, perdersi nei loro deliri e assecondare benignamente le loro fissazioni.
C’era un uomo, vecchio e dalla pelle scura e accartocciata, che ci chiedeva sempre una sigaretta nonostante una fosse accesa nella sua bocca e una perennemente ardesse tra il suo indice e il medio ustionandogli l’interno delle dita lasciandogli sempre aperta una piaga rossa e mai curata. Il silenzioso uomo con l’impermeabile nero che si muoveva a scatti e pensava di essere Hitler era uno dei più disperati, con quella palandrana nera d’estate e d’inverno borbottava parole senza senso ma, forse sarebbe stato necessario prestargli maggiore attenzione per capire, l’ombrello al braccio e la camminata incerta cercava riparo dalla vita passando rasente i muri e si accoccolava dietro ogni albero che incontrava sul suo cammino. E quella donna, una vecchia, che per cento lire ti prometteva “le sue grazie”. Per cento lire!

Quell’immensa città che era il manicomio adesso è stata “riqualificata”, i suoi parchi sono stati rimessi a nuovo e gli edifici ripuliti, riverniciati e resi consoni ai nuovi usi. La memoria di coloro che lì hanno sofferto e si sono spenti ogni giorno per anni è stata cancellata da una mano d’intonaco ma i fantasmi delle persone che lì dentro sono impazzite davvero e sono state dimenticate da tutti secondo me ancora ci sono.
Tutto questo è quello che mi ha fatto venire in mente l’opera dell’artista brasiliano Herbert Baglione 1000 shadows realizzata nell’ex manicomio di Parma nel 2013 (vedi immagini).
Anime e fantasmi neri allungati in corridoi scrostati e abbandonati, ombre di persone che sono state volontariamente estromesse dalla società dei “normali”, colpe che non hanno trovato colpevoli, silenzi assordanti che avrebbero invece dovuto essere grida, sopratutto politiche.
Perché non di ospedali psichiatrici parliamo ma di mattatoi dell’io.